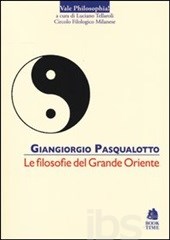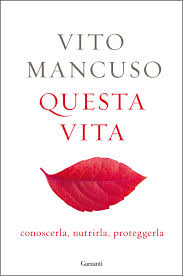Un manuale di filosofia – con tutti i limiti del genere – scritto con stile limpido e rigoroso da uno dei più importanti filosofi italiani viventi
Voto 6,5
Ho comprato il volume “La filosofia nel Novecento” perché in generale conosco poco gli autori appartenenti a questo periodo storico (a parte poche eccezioni) e perché mi sembrava importante formarmene un’immagine più chiara – per capire meglio i tempi attuali, che del pensiero del novecento sono in qualche misura figli. Non da ultimo, mi interessava utilizzare i rinvii necessariamente veloci ai singoli pensatori come una ricca raccolta di spunti, tracce per ulteriori approfondimenti.
Il testo si caratterizza per “…la rappresentazione di scene teoriche compatte, scandite per quadri concettuali, in cui i protagonisti intrecciano in maniera avvincente i loro argomenti nello sforzo di chiarire problemi che sono anche nostri”.
Il quadro d’insieme del Novecento che emerge è sintetizzato da questo passo eloquente: “Nella cesura netta con il proprio passato personale, resa possibile dalla revocabilità degli impegni, nell’infedeltà persino a se stessi…si manifesta – assieme a una maggiore libertà e scioltezza dell’individuo – anche il suo progressivo isolamento…l’allentamento dei vincoli con gli altri. Privato del pieno e organico inserimento nei “corpi intermedi” che l’avvolgevano (famiglia, comunità di vicinato, ceto o classe) e posto a diretto contatto con i suoi simili e con le istituzioni, egli è insieme più libero e più solo”. E’ questa un’immagine nitida dei nostri tempi, che tutto il testo attraversa lasciando ai margini concetti e problematiche di volta in volta diverse, ma unite dalla sensazione della perdita di un vero “centro di gravità permanente”.
Non mi è possibile qui scendere nel dettaglio delle figure dei singoli filosofi, ma posso fare un bilancio d’insieme che forse può aiutare il lettore interessato.
Rispetto alle attese, il libro si conferma una raccolta di spunti ricca e interessante. A ciascun pensatore è dedicato uno schizzo, compilato generalmente in modo molto acuto, attento al confronto di idee nel cui quadro il pensatore stesso si muove e assume rilevanza.
Ma conferma anche un’altra cosa: la storia della filosofia intesa come dinamica e confronto dei concetti nella storia rischia di perdere proprio ciò che è essenziale alla filosofia, ossia la dimensione della totalità. Tutte le filosofie degne di questo nome hanno quest’unico oggetto, il Tutto. E perciò io credo che ciascun filosofo rappresenti la totalità (e allo stesso tempo la totalità della filosofia) da un proprio unico ed esclusivo punto prospettico.
E’ per questa ragione che solo un approfondimento “verticale” del pensiero di un filosofo renda ragione della e dia un senso alla sua “posizione”. Altrimenti la filosofia si trasforma in storia dei concetti, che vengono comparati in maniera estrinseca, orizzontale, perdendo la dimensione “verticale” che rappresenta l’autentica ricchezza della interrogazione filosofica.
Il voto è un riconoscimento all’intelligenza e all’acume di Bodei, ma il suo testo (come tutte le storie dei concetti) ha poco senso senza un successivo approfondimento delle tematiche affrontate, ed ha pertanto solo un’importanza preliminare.
Buona lettura
http://www.ibs.it/code/9788807887000/bodei-remo/filosofia-nel-novecento.html