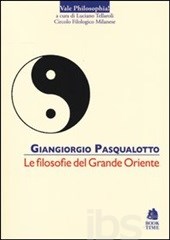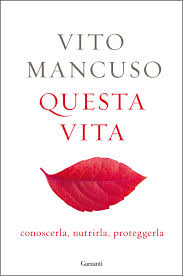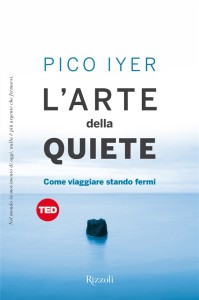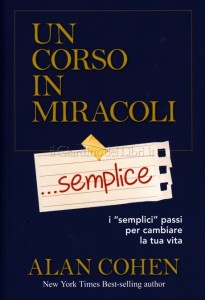
Un libro agile che introduce ai grandi temi di Un Corso in Miracoli in modo efficace e a tratti entusiasmante
Voto 8
Un corso in miracoli è un classico della spiritualità che, dall’anno di pubblicazione (1976) ad oggi è stato letto da milioni di persone.
E’ stato scritto da due psicologi della Columbia University, la dottoressa Helen Schucman e il dottor Bill Thetford. La Dottoressa Schucman, in un periodo particolare della sua vita, iniziò a sentire una voce in sé stessa che le dettava dei contenuti particolarmente significativi, e decise di appuntarsi giorno per giorno ciò che le veniva dettato; il dott. Thetford trascriveva gli appunti filtrandoli grazie alla sua esperienza clinica.
Il libro nella sua versione definitiva, dopo 8 anni di lavoro, è “un metodo di risveglio spirituale per autodidatti, che insegna la via della pace interiore e della guarigione attraverso il potere dell’amore e del perdono”, è una sorta di “GPS spirituale” che si materializza quando siamo stanchi di “razzolare nel fango come i maiali”, “sentiamo che la vita che stiamo vivendo non può essere quella che Dio voleva per noi, e diventiamo impazienti di tornare alla nostra vera casa”.
Tuttavia, il Corso in Miracoli di per sé è un testo lungo e impegnativo, e per questo potrebbe non risultare di facile accesso.
Alan Cohen, un riconosciuto maestro del Self Help (ricordiamo di lui anche “Tutto il bello che c’è” e “Perché la tua vita fa schifo…e cosa puoi farci”) che tra l’altro ha dalla sua una più che trentennale conoscenza (e insegnamento) del Corso, ci guida, nel suo nuovo libro “Un corso in miracoli…semplice”, alla scoperta dell’essenza del testo in questione.
Il libro di Cohen in edizione italiana conta 235 pagine (contro le oltre 1300 del Corso) ed è scritto in maniera semplice e accattivante.
Di fatto, il libro ripercorre i concetti fondamentali del Corso, con una grande ricchezza di esempi concreti che ne rendono più semplice la fruizione.
Il tema tuttavia resta sempre lo stesso cioè quale sia, che significato abbia per noi e come si debba percorrere, la via dello Spirito.
Gli spiritualisti o idealisti di ogni scuola, accomunati dalla fiducia incrollabile nell’Unico Spirito come superiore e precedente alle molteplici forme determinate (che tuttavia restano a loro volta all’interno dello spirito in quanto loro condizione di possibilità), riconosceranno molti spunti importanti in questo volume di Cohen, e saranno spinti a leggersi il più impegnativo Corso in Miracoli in versione integrale.
“La tua verità autentica è solo e unicamente spirituale. Tu non sei il tuo nome, la tua età, il tuo peso, il tuo indirizzo, la tua religione, il tuo stato civile, il tuo conto in banca, la tua diagnosi medica, o qualsiasi altro attributo con cui il mondo ti identifica. Anche se la società ti dà etichette diverse a seconda dei parametri a cui fa riferimento, tu resti integro così come sei stato creato […] con la dignità della tua identità divina”
E questa verità non lascia indifferenti, non è solo parola, ma si fa riferimento per sollevarci alla nostra più vera condizione, oltre e fuori dalle trame del mondo e della mente:
“La mente, piena di paure, tesse una rete di complessità che fa sembrare impossibile sfuggire alle traversie del mondo. Il corso ci dice invece che la vita non deve essere per forza dura e che è perfettamente possibile sfuggire al mondo fabbricato dalla paura. Riduci ogni scelta a ciò che fa bene e a ciò che fa male e rispondi alla paura con l’amore, così troverai la pace che cerchi”
Sorge quindi nello Spirito uno scopo del tutto nuovo: “Tu pensavi di essere qui per ottenere beni materiali, dimostrare il tuo valore e trovare persone che ti amassero. Invece sei qui per ottenere pace, essere te stesso e trovare persone da amare. Pensavi di essere qui per sistemare il mondo. Invece sei qui per apprezzare quello che hai davanti e vedere il mondo con occhi nuovi. Pensavi di essere qui per insegnare, mentre sei qui per imparare”. Che cosa? Che “Sei una creatura d’amore in un universo fondato sull’amore”, e questo alla fine – ci dice Cohen – è ciò che insegnerai.
Buona lettura a tutti!